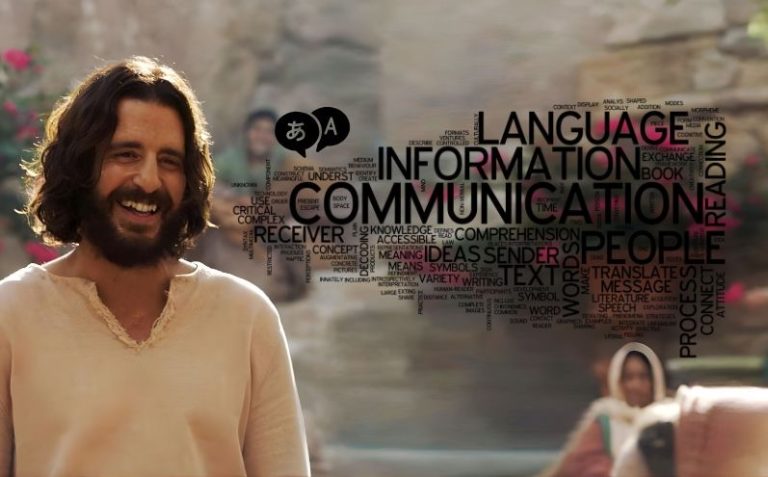Quando si ascolta Jerry Siegel e Joe Shuster ripensare alle origini di Superman, è difficile individuare un’influenza religiosa evidente nel loro processo creativo.
Al contrario, i due autori, ormai scomparsi, attribuivano l’idea del “giornalista mite e riservato con un super-segreto” alla loro passione per la fantascienza d’epoca e all’ammirazione per le acrobazie atletiche di Douglas Fairbanks e le scene di lotta di Harold Lloyd.
Lontano da qualsiasi riferimento biblico palese, il debutto del personaggio nel fumetto Action Comics #1 del giugno 1938 racconta di un neonato Superman inviato sulla Terra da uno scienziato alieno, ritrovato da un “automobilista di passaggio”, che lo consegna a un orfanotrofio cittadino.
Nel contempo era il nono anno di una crisi economica globale che aveva reso le persone affamate non solo di cibo.
E qualcosa di quel personaggio così insolito, nato dall’ingegno di due giovani cresciuti frequentando la scuola ebraica a Cleveland, Ohio, colpì profondamente l’immaginazione degli americani.
Un fascino che si rinnova ancora oggi, con l’uscita di Superman diretta da James Gunn proprio in queste settimane.
Simboli di fede

Un elemento della storia originaria riflette chiaramente le radici religiose dei suoi autori: un bambino salvato dalla distruzione dai genitori, spedito in una piccola navicella, cresciuto da persone estranee, e che poi riscopre la sua identità come “difensore degli oppressi”.
Pur richiamando la vita di Mosè (e forse ispirato anche da Sansone, il fortissimo eroe del Libro dei Giudici), questo personaggio incarna anche l’antica speranza ebraica nella venuta di un Messia — colui che “proclamerebbe la libertà ai prigionieri e l’apertura delle prigioni a chi è incatenato”.
Quella citazione dal Libro di Isaia è oggi associata dai Cristiani a Gesù, come avvenne anche quando Gesù stesso la citò nella sinagoga di Nazaret.
Sei mesi dopo la prima striscia a fumetti, il 17 gennaio 1939, compare per la prima volta il nome “Kal-El” su una striscia giornalistica (dove “El” significa Dio in ebraico e, in kryptoniano, “Figlio”).
Poco più tardi, nello stesso anno, emergono toni più esplicitamente cristiani: nella revisione del 1939, Superman viene adottato da Mary e da un marito senza nome (che nel 1951 diventerà Jonathan, mentre Mary diventerà Martha).
Riferimenti a Cristo nei film

In una tesi del 2002 intitolata Superman as Christ‑Figure: The American Pop Culture Movie Messiah, Anton K. Kozlovic ha individuato venti riferimenti a Gesù nelle pellicole su Superman.
Alcuni sottili, come l’ambientazione rurale e il ruolo di “padri adottivi” umili e laboriosi; altri più espliciti, come in Superman: The Movie (1978), quando il vero padre di Clark Kent afferma:
“Potrebbero essere un grande popolo, Kal-El. Lo desiderano. Hanno soltanto bisogno di luce per trovare la via. E proprio per questo, per la loro capacità di fare del bene, ti ho mandato, mio unico figlio.”
Nessun film ha esplorato i temi cristiani con la stessa intensità di Superman Returns (2006) di Bryan Singer, e di Man of Steel (2013) e Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) di Zack Snyder.
Queste opere mettono in scena una serie di richiami simbolici: una nascita straordinaria, la guida spirituale di un padre sovrannaturale, la scoperta dei poteri a 33 anni, la resa volontaria alle autorità, la ferita al fianco, la caduta con il corpo in posa crocifissa dopo un sacrificio per salvare l’umanità, il risveglio dopo tre giorni e infine il ritorno dopo una lunga assenza.
Una fame universale di salvezza
Ogni racconto su Superman, sia fumettistico che cinematografico, si concentra su situazioni disperate: un bambino che precipita nelle cascate del Niagara, un autobus scolastico che finisce in un fiume, una struttura d’acciaio che minaccia di crollare su una folla cittadina.

La morte appare imminente, inevitabile. Fino a quando interviene Superman. Nessuna scena ha catturato meglio questo momento drammatico dell’aereo che si schianta in Superman Returns.
“Questa è parte del fascino di Superman,” disse E.G. Marshall, che interpretava il presidente degli Stati Uniti nel film del 1980 con Christopher Reeve.
“La speranza — anzi, la possibilità — che esista un super‑essere, una forma di superuomo, un’intelligenza superiore alla nostra.”
E aggiunse: “E che, un giorno, riusciremo a entrare in contatto con quella vita.”
David Corenswet, interprete del nuovo Superman, originario di Philadelphia e padre di un bambino di un anno, afferma che il personaggio è “decisamente diverso da chiunque altro sulla Terra — non è umano… e possiede poteri che nessun altro ha”.
“E al contempo desidera con tutto sé stesso far parte dell’umanità.”
Quel lato umano è il punto in cui le diverse versioni di Superman si differenziano di più.
La bontà come vera provocazione?

In Superman III, Christopher Reeve sperimenta un lato oscuro: rabbia, imprudenza e perfino crudeltà. In Man of Steel, Henry Cavill infrange “la regola” dei supereroi uccidendo il malvagio Generale Zod. Su Real Clear Religion, Jeff Weiss commentò: “Non uccidere, anche se puoi.”
In un’altra recensione su Christianity Today, Jackson Cuidon osserva che l’immagine più aggressiva e “maschia” di Superman serviva “a soddisfare quella parte della psiche americana che desidera un Messia capace anche di tirare pugni”.
James Gunn, con il nuovo Superman, compie una scelta consapevole: il personaggio va finanche a salvare la vita di uno scoiattolo ed è descritto come “non indistruttibile” — tanto che lo vediamo sanguinare nella scena iniziale.
Scompaiono i toni cupi, l’angoscia esistenziale e gli eroi tormentati, tanto criticati nell’universo di Snyder. Questo nuovo Superman indossa colori vivaci, sorride spesso e si preoccupa del suo cane — mentre i supereroi intorno a lui risultano quasi buffi.
Un’energia positiva e carica di speranza, racchiusa nello slogan del film: Look up (“Guarda in alto”).
La bontà di Superman occupa il centro del film.
«Io metto tutto e tutti in discussione», confida Lois Lane a Clark Kent parlando delle band punk amate nella loro giovinezza. «Tu credi che tutte le persone che incontri siano bellissime.»
«Forse questo è il vero spirito punk,» risponde lui.
«La trasgressione è ormai scontata e logora,» riflette lo scrittore cristiano Brett McCracken, «La normalità è il nuovo radicale.»
Scoprire questa bontà dentro di noi può ispirare le persone a vedere nel supereroe un modello. Interrogato sul messaggio che sperava lo spettatore cogliesse dal suo Superman, Gunn rispose: “Dare maggiore importanza all’essere buoni esseri umani.”
“Siamo circondati da tanta cattiveria,” proseguì. “Superman, nel film, vive in mezzo alla cattiveria. Ma lui decide di andare controcorrente. Ed è proprio questo che lo rende ribelle.”
“In un certo senso, oggi Superman è il personaggio più provocatorio, perché è colui che difende valori che la maggioranza ha dimenticato.”
Superman: Echi del “mito vero”

Come può tutto questo derivare da una favola creata da due giovani ebrei poco osservanti?
Forse, al di là di qualunque intenzione religiosa, emerge un bisogno umano profondo: aspirazioni che risuonano nei miti antichi, come gli eroi greci che sacrificano la vita per salvare il loro popolo; nei racconti moderni di Frodo impegnato nella distruzione dell’anello; o nelle avventure di Harry Potter come “il prescelto”.
J.R.R. Tolkien sosteneva che tutti i miti siano echi filtrati del “mito vero” rappresentato da Gesù Cristo.
Ricordando una passeggiata a Oxford con Tolkien da giovani trentenni intenti a discutere su questo tema, C.S. Lewis raccontò in seguito ciò che lo colpì maggiormente:
“La storia di Cristo è semplicemente un mito vero: funziona su di noi come tutti gli altri miti, ma con la differenza straordinaria che è veramente avvenuta”.
Fu solo nove giorni dopo quella conversazione, il 28 settembre 1931, che Lewis confessò per la prima volta la propria convinzione nella reale divinità di Gesù Cristo.
In seguito, Lewis avrebbe insegnato che tutti i miti contengono scintille di verità e rimandano a livelli di realtà più profondi, anche quando gli eventi narrati non sono accaduti letteralmente.
O anche quando gli autori originali del mito non avevano mai voluto attribuirgli un significato più profondo.
Questo articolo è stato pubblicato su https://www.deseret.com. Questo articolo è stato tradotto da Ginevra Palumbo.